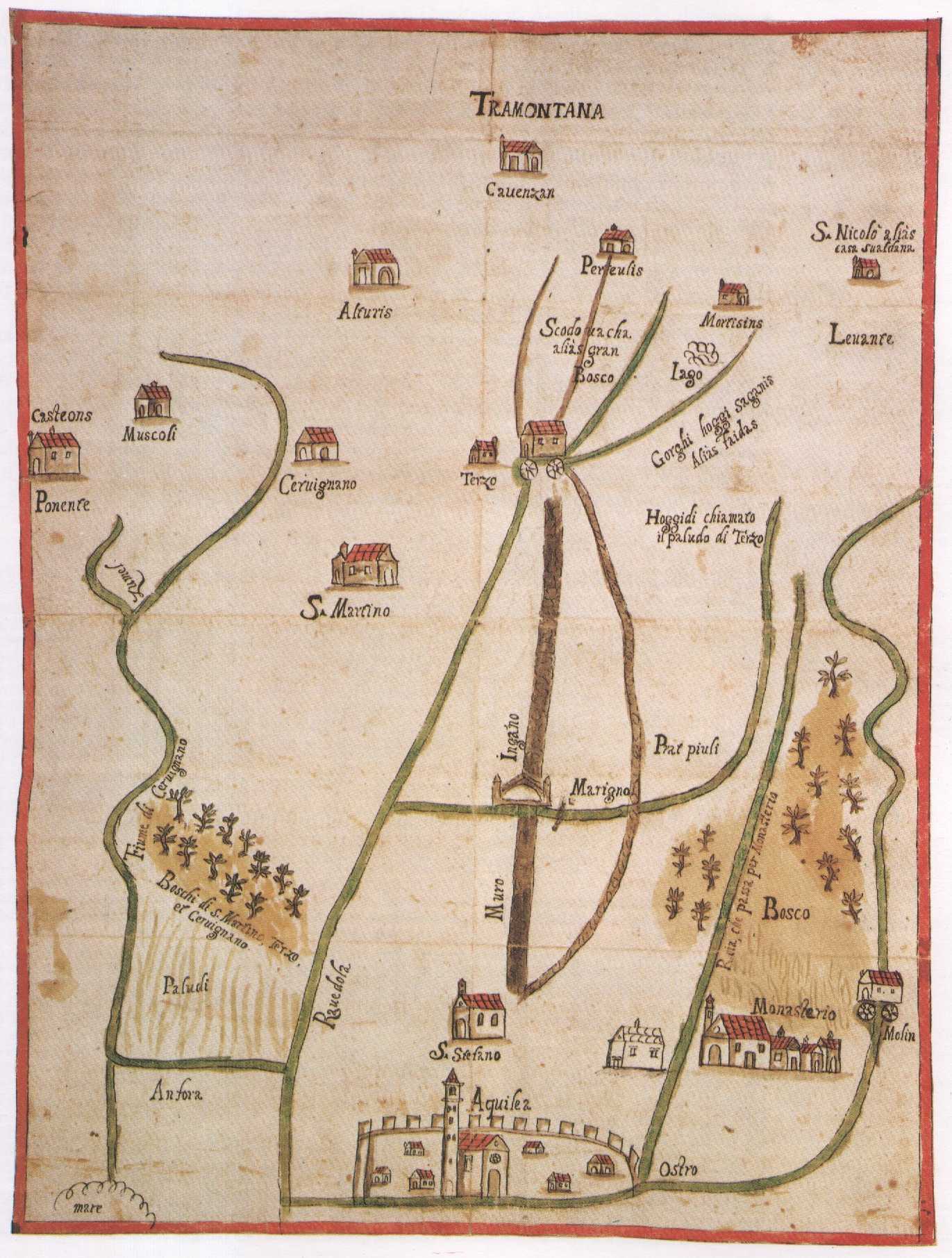
Nascita
del cognome
in
Italia
Nell’epoca
cristiana il primo uso documentato di veri e propri cognomi si riscontra nel
Veneto e più precisamente a Venezia. Già gli antichi romani adoperavano i
cognomi: anzi, ogni rispettabile cittadino era normalmente designato con
il nome proprio, con il nome gentilizio (cioè della gens o famiglia cui
apparteneva) e con il “cognomen” ovvero soprannome, facoltativo. Prendiamo
ad esempio il nome del più famoso oratore: Marco Tullio Cicerone. Esso stava ad
indicare un individuo denominato Marco, della famiglia dei Tullii, il cui
soprannome faceva Cicero, cioè “bruffoletto“; il signor Bruffoletto,
appunto. Poi sopravviene il crollo dell’impero romano e gli uffici anagrafici
vanno a catafascio con tutto il resto.
I cristiani
dei primi secoli si conoscevano fra loro soltanto con il nome di battesimo, che
poteva essere di estrazione ebraica, greca, romana o germanica. Nei casi ambigui
si ricorreva all’aggiunta del nome del padre (patronimico). Ciò perché un
Tizio figlio di Caio non corresse il rischio di essere scambiato con un altro ed
omonimo Tizio, figlio di Sempronio. La faccenda, è arguibile, poteva avere dei lati seccanti nel
caso di mandato di cattura o di riscossione delle imposte. Volta per volta, l’immortale categoria degli Amici Burloni
provvedeva di sua iniziativa ad appioppare un qualche nomignolo su misura.
Sono appunto i patronimici ed i nomignoli che formano la base dei moderni cognomi.
I cognomi,
come ora li intendiamo, nascono e diventano di uso comune con l’estendersi
della scrittura. Quando l’analfabetismo regnava sovrano (tant’è vero che
imperatori come Carlo Magno erano analfabeti) i nomignoli e i patronimici
individuali morivano regolarmente (e si potrebbe dire giustamente) con la
persona che li portava. Ma non
appena cominciano ad essere messi su carta dalla penna d’oca di uno scrivano,
essi manifestano la tendenza a trasformarsi da nome di un singolo a
denominazione di gruppi familiari e
cristallizzarsi.
Per
spiegarci con un esempio, supponiamo il
caso di un artigiano veneziano del XIII secolo o giù di lì, che la voce
popolare designava comunemente come
“Giovanni il Rosso”, o meglio “Zan il Rosso” senza dubbio per via del
colore dei capelli. Un bel giorno il nostro uomo si presenta dal notaio per
riscuotere i quattro ducati di una piccola eredità e il suo nome viene messo
per la prima volta sulla carta, nero su bianco. Oppure è il “piovano” che
si prende la briga di annotare il nome nei
registri parrocchiali e che indica un battezzato, indicandolo come “Piero di
Zanrosso”. Il cognome Zanrosso è nato e sarà portato per secoli dai
discendenti, anche se nessuno di questi avrà, metti caso, il privilegio di un
ciuffo color carota paragonabile a quello del loro antenato. Sembra che i notai
e i piovani di Venezia fossero particolarmente zelanti in questo genere di
faccende. E’ infatti a Venezia, come si diceva, che si registrano i primi
esempi documentati di cognomi scritti e stabilmente fissati per designare un
gruppo familiare.
Le
modeste origini, come quella descritta nell’esempio, sono per lo più alla
base della sterminata varietà dei cognomi in uso. Ci sono cognomi comunissimi
e cognomi eccentrici. Cognomi
buffi che pesano come una maledizione sugli sfortunati che li portano. Cognomi
neutri e modesti come un abito grigio rivoltato per economia. Cognomi pomposi e
perentori come il colpo di grancassa che chiude un prologo wagneriano; altri
difficili da ricordare come la capitale del Madagascar; taluni bizzarri come uno
scioglilingua. Cognomi che al telefono assolutamente non si capiscono. Ci sono
cognomi etimologicamente trasparenti e cognomi la cui interpretazione richiederebbe
il fuori orario di una commissione di esperti. Ma tutti i cognomi hanno il loro
perché.
I cognomi patronimici sono forse i più
numerosi. Sono quelli che hanno
alla base il nome di un santo del calendario. Molto spesso, però, questi nomi
hanno subito deformazioni foniche che li rendono irriconoscibili. Così, se è
evidente che il cognome come “Tonini” non può derivare che da
‘Antonio”, difficilmente un qualsiasi signor “Serato” o
“Sarotto”’ sospetterà che il suo cognome è tributario di Baldassare.
Il cognome “Vianello” (senza dubbio il più diffuso dell’anagrafe
veneziana) viene da “Viviano” e i primi Vianello, o “Vivianello”
arrivano a Venezia dalla Toscana nel XVI secolo e si acquistano fama,
documentata dai cronisti, di “grandissimi homeni de faccende”. In molti casi
l’etimologia è particolarmente difficile perché risale a nomi ormai
scomparsi dall’uso e che sono, invece, comuni nel Medioevo, allorché rudi
genitori non esitavano un istante ad affibbiare a innocenti neonati nomi propri
come Ercio, Natanaele, Gundaforo oppure
- se il neonato era una femminuccia – Arfedovia, Gualfarda, Rechentaria…
Strano che nessuno storico abbia pensato al dramma psicologico di un fidanzato
medievale dotato di un minimo di sensibilità poetica, che aspirasse alla mano
di un’affascinante donzella appellata “Rechentaria”.
Quasi altrettanto ampia è la categoria dei cognomi derivanti da soprannomi veri e propri. Qui entrano in scena tutte le possibili deficienze o qualità, fisiche o morali, che possono contraddistinguere un individuo. Ma l’evoluzione del dialetto, che è sempre alla base del nomignolo originario, fa sì che, anche in questo caso, la radiografia di molti cognomi sia problematica. Per fare qualche esempio tratto dal fertile campo dei cognomi veneti, accanto a cognomi-nomignoli abbastanza evidenti come “Nason” o “Gobbo” o “Bellotto” ecco tutta una serie di cognomi-rebus la cui spiegazione esige la conoscenza di antiche voci dialettali più o meno scomparse: è il caso di “Baghin” (da “baga”, otre), di “Inguanotto” (“inguana” era la strega), di “Sabbadin” (nato di Sabato), di “Sbisà” (che starebbe per “Stolido”), di “Zanchi” (come dire “mancini”) e via esemplificando.
Spesso il cognome ha origine da nomi di mestieri esercitati dagli avi; da
appellativi indicanti dignità o
parentele; da nomi comuni di bestie o di piante. Anche in questi casi
l’identificazione dell’etimo può riuscire difficile. Poi ci sono,
abbastanza diffusi, cognomi rispecchianti derivazioni geotopografiche oppure
appellativi etnici; è i il caso di “Canal” di “Pozzo”, di “Costa”;
come pure di “Crovato” (croato), di “Spagnol” di “Todesco” di
“Schiavon” di “Bressan” (bresciano), di
“Bergamin” , ecc…
Cartina del territorio della Bassa Friulana all’inizio del 1700.